![[South Sudan Rebels]. Credits to AD Photo](http://www.thezeppelin.org/wp-content/uploads/2020/04/ad-photo-sudan.jpg)
Se nessun continente è immune dall’oppressione, dai crimini contro l’umanità e, in caso di conflitti armati, dai crimini di guerra, l’Africa Subsahariana non fa certo eccezione, anzi è stata teatro di alcuni tra i conflitti più violenti registratisi negli ultimi decenni, conflitti settari ed etnici che nel caso del Ruanda e del Darfur sono degenerati in genocidio.
La seconda guerra del Congo e la minoranza Bambuti
Anche qui l’avvento del XXI secolo non ha generato un miglioramento apprezzabile. Proprio gli albori del nuovo millennio hanno visto il continente africano divenire il campo di battaglia di un conflitto che ha coinvolto otto paesi. Nel 1998 gli eserciti del Ruanda e dell’Uganda sono penetrati in profondità nel territorio della Repubblica Democratica del Congo con l’obiettivo di detronizzare il presidente Kabila, che loro stessi avevano appoggiato nella sua lotta per il potere. Soltanto l’intervento degli eserciti dello Zimbabwe e dell’Angola, a fianco delle truppe congolesi, ha consentito di arrestare l’avanzata ugando-ruandese. Il conflitto che ne è scaturito è durato 5 anni e sebbene non sia possibile determinare con precisione il numero di vittime che ha generato, gli studiosi ritengono che sia costato la vita a 3,9 milioni di esseri umani. Per di più la guerra ha determinato la presenza di 3,7 milioni di profughi e di 17 milioni di persone a rischio di morire di fame. Inoltre gli stupri massivi che hanno accompagnato le ostilità o il contatto con sangue infetto durante i combattimenti hanno fatto registrare 1,3 milioni di contagi da HIV.
Tutte le fazioni belligeranti supportavano gruppi di ribelli armati che agivano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo, in particolare nelle regioni orientali. La firma del trattato di pace, avvenuta nel 2003, non ha visto una diminuzione delle faide tra i diversi gruppi di ribelli e la situazione nella regione dell’Ituri è rimasta critica nonostante il ritiro entro i propri confini degli eserciti di Uganda e Ruanda. In queste aree del paese persino il contingente militare della missione inviata dalle Nazioni Unite (MONUC) per monitorare il rispetto degli accordi di pace subiva continui attacchi dai paramilitari. Le popolazioni civili ed i profughi presenti sul territorio rimanevano in balia dei sanguinari comandanti delle diverse milizie ribelli. Il controllo dell’Ituri faceva gola a così tante fazioni perché si tratta di una regione ricca di oro, diamanti, cobalto e rame. Secondo un rapporto dell’Onu, tutte le forze in gioco in quest’area, sia quelle regolari che quelle irregolari, hanno estratto o rubato materie prime in grandi quantità. Con la fine del conflitto, Uganda e Ruanda hanno continuato a finanziare ed armare le milizie paramilitari che avevano appoggiato quando le ostilità erano ancora in corso, in modo che queste ultime procedessero nell’attività di estrazione illegale di risorse minerarie.

Tra le popolazioni civili che abitano l’Ituri vi sono anche gli appartenenti alla tribù Bambuti. Si tratta dei cosiddetti Pigmei dei Grandi Laghi, una popolazione antica che si pensa essere stata la prima ad abitare le foreste equatoriali dell’Africa centrale. Il fatto che i membri di questa tribù non possiedano documenti di identità, non siano mai stati censiti dal governo congolese e si siano dispersi a seguito del conflitto, non ci permette di sapere esattamente il numero degli appartenenti alla minoranza Bambuti.
Leggi anche: L’umanità residuale: le popolazioni indigene
Si stima che si tratti di una popolazione di circa 30 mila persone. I Bambuti congolesi sono fortemente discriminati nel paese. Essi vivono in villaggi sperduti all’interno delle foreste, spesso a più di un giorno di cammino dalla strada più vicina. Sono dunque quasi completamente tagliati fuori da tutti i più elementari servizi. Non ricevono alcun aiuto allo sviluppo, sopravvivono cacciando, pescando, coltivando tuberi oppure lavorando in miniere “artigianali”. Durante il conflitto i Bambuti dell’Ituri e del Kivu non hanno preso le armi, preferendo non schierarsi. Nonostante ciò sono divenuti un bersaglio per i gruppi paramilitari.

La loro conoscenza delle foreste ha determinato il loro arruolamento coatto come guide da parte delle milizie regolari ed irregolari che si trovavano nelle regioni orientali del Congo. Questo li ha esposti alle vendette dei gruppi armati rivali. In aggiunta, si sono diffuse alcune credenze popolari che hanno gravemente danneggiato i membri delle comunità Bambuti. Il fatto che i miliziani credessero che alcuni problemi di salute, come il mal di schiena, potessero essere guariti giacendo con le donne Bambuti è stata la causa di numerosi stupri.Inoltre il clima di totale impunità che regnava nella regione e la mancanza di qualsiasi tipo di tutela per i Bambuti ha fatto sì che tutti i gruppi militari commettessero crimini odiosi contro di loro. Nei dintorni della città di Mambasa, passata più volte di mano durante i combattimenti, circa 100 mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Tra queste anche un grande numero di Bambuti, particolarmente perseguitati perché accusati di aver collaborato di volta in volta con le varie milizie che prendevano via via il controllo della città.Secondo il rapporto presentato da Minority Rights Group International presso le Nazioni Unite, i miliziani derubavano i Bambuti di tutto quello che possedevano. Poi procedevano con lo stupro sistematico delle donne, mentre costringevano gli uomini, violentemente picchiati in precedenza, a guardare. Alcuni testimoni hanno raccontato di come i miliziani si introducessero nei villaggi nottetempo e aprissero il fuoco su chiunque vedessero, comprese donne e bambini. Prima di andarsene bruciavano tutto. Soltanto alcuni fortunati riuscivano a salvarsi.È ricorrente in tutte le testimonianze il fatto che i militari dicessero ai Bambuti di considerarli alla stregua di animali. Esistono testimonianze, portate davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, di Bambuti cannibalizzati dai miliziani, i quali credevano che le loro carni fossero curative. Sebbene siano rare le testimonianze di cannibalismo, in tutti i racconti dei Bambuti sopravvissuti è ricorrente la minaccia, da parte dei militari, di cibarsi di loro se non gli avessero procurato carne di capra.Gli stupri, le deportazioni forzate, le torture, gli omicidi di massa e gli altri terribili crimini commessi nei confronti dei Bambuti, con il chiaro ed espresso intento di discriminarli in quanto considerati subumani, ci consentono di parlare di genocidio secondo i criteri stabiliti dal diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni internazionali che riguardano la materia.

Purtroppo non è possibile ricostruire un dato numerico che ci permetta di comprendere quanto sia stato esteso il fenomeno in esame, a causa della totale mancanza di collaborazione da parte delle autorità congolesi e della stessa difficoltà nel censire gli appartenenti alla tribù dei Bambuti.
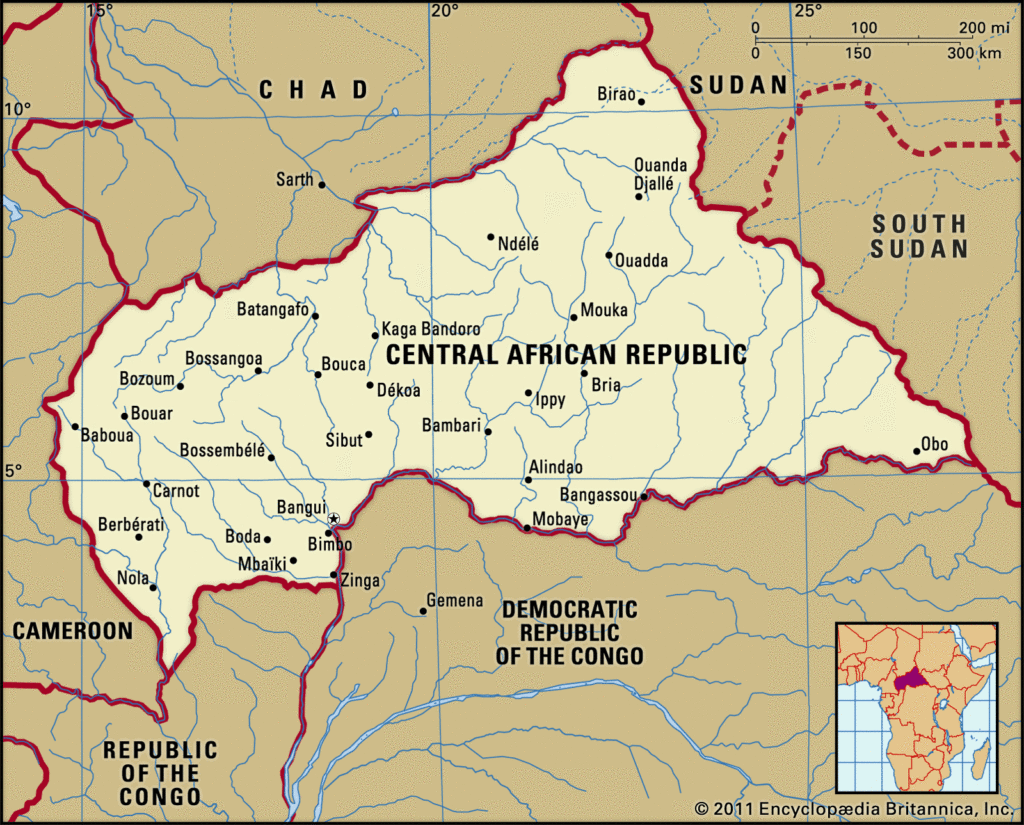
Come è facile immaginare, il caso congolese non è l’unico ad aver infiammato l’Africa Subsahariana.
La guerra civile nella Repubblica Centrafricana
Nel 2012 è cominciata la guerra civile nella Repubblica Centrafricana. Il conflitto non è ancora terminato, nonostante la presenza di una missione dell’Unione Africana e l’intervento di un contingente militare francese. Le cause della guerra civile sono da ricercare nel mancato rispetto degli accordi che avevano concluso il precedente conflitto che aveva devastato il paese. I trattati prevedevano infatti l’integrazione di numerosi ex ribelli tra i ranghi dell’esercito regolare centrafricano, ma il presidente Boizizé non ha mai permesso che questo avvenisse. Le milizie islamiche Seleka che avrebbero dovuto usufruire di detti accordi, hanno ripreso le armi contro il governo e sono scese fino alla capitale del paese, costringendo l’autoritario Boizizé a riparare in Camerun.Come spesso accade in Africa, il conflitto è degenerato, trasformandosi in una guerra di religione. Se le milizie ribelli sono islamiche, l’80% della popolazione centrafricana è di religione cristiana. È nato così il fronte cristiano Anti-balaka, che ha preso le armi per combattere contro i ribelli musulmani provenienti dal nord del paese.

Entrambe le fazioni in lotta, composte da numerosi gruppi paramilitari, si sono macchiate di orribili crimini contro la popolazione civile. Sia i cristiani che i musulmani sono vittime di crimini contro l’umanità. Soltanto nel primo anno di guerra sono stati uccisi tra i 3 mila ed i 6 mila civili.
Human Rights Watch riporta testimonianze di omicidi di massa, stupri e violenze su donne e bambini, arruolamento coatto di bambini soldato, diffuse torture, villaggi completamente rasi al suolo o bruciati, campi profughi assaltati e numerosi civili rapiti o utilizzati come ostaggi. Vista la situazione del paese, che è al collasso, è negata ogni possibilità di accesso alla giustizia per le vittime dei gravissimi crimini che tutt’ora vengono perpetrati. Il clima di impunità che si respira nel paese è tale che persino i giornalisti e gli operatori umanitari sono diventati dei bersagli.

Si calcola che all’interno del paese vi siano 600 mila profughi, mentre 591 mila persone si sono rifugiate presso le nazioni confinanti. Oltre 2,5 milioni di persone (su una popolazione totale di 4,6 milioni) hanno urgente bisogno di aiuti umanitari.
Il caso del Sud Sudan
Ben più noto è invece il caso del Sud Sudan, per molti versi simile a quello della Repubblica Centrafricana. Non si tratta infatti della persecuzione di una minoranza da parte di un governo o di un altro gruppo etnico, bensì di due etnie in guerra tra loro che commettono gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario nei confronti della popolazione civile della parte avversa. A differenza del caso Centrafricano, però, la rima di frattura non è religiosa ma etnica.

Il Sud Sudan ha proclamato la propria indipendenza dal Sudan nel 2011, dopo anni di guerra civile.
Leggi anche: Storia del più giovane degli stati
Il paese è abitato da numerosi gruppi etnici, tra i quali è maggioritario quello dei Dinka (35,8% della popolazione), immediatamente seguito dall’etnia Nuer (15,6%). Il presidente del Sud Sudan, Kiir appartiene al primo gruppo. I Nuer erano rappresentati nel governo dal vicepresidente Riek Machar. Nel luglio del 2013 il presidente Kiir ha sostituito completamente i membri del governo, compreso il vicepresidente Machar. Ciò ha scatenato la ribellione della popolazione di etnia Nuer, trascinando il paese in una sanguinosa guerra civile.

Dall’inizio delle ostilità, sono stati numerosi i tentativi di riportare la situazione sotto controllo, cercando di raggiungere un accordo di pace tra le fazioni in lotta. Come spesso accade in questi casi, i cessate il fuoco non sono stati rispettati ed ogni tentativo di porre fine alla violenza diffusa nel paese è risultato vano. Il conflitto ha determinato la morte di decine di migliaia di persone e si calcola che nel paese ci siano oltre 4 milioni di profughi.
I rapporti delle Nazioni Unite sulla regione hanno sottolineato come entrambe le fazioni in lotta, l’esercito regolare ed i gruppi paramilitari ribelli, si siano macchiati dei peggiori crimini contro la popolazione civile. Anche in questo caso si parla di omicidi di massa, stupri, torture ed arruolamento coatto di bambini soldato. I testimoni oculari delle stragi riportano che in molti casi le persone venivano bruciate vive insieme ai loro villaggi. Il fatto che alla base delle violenze ci sia una discriminante di tipo etnico, ha fatto sì che le Nazioni Unite parlassero di pulizia etnica ed allertassero la comunità internazionale sul rischio concreto di assistere ad un genocidio.
Human Rights Watch calcola, nel suo report annuale, che dei 4 milioni di profughi ben 2,47 milioni si siano rifugiati nelle nazioni confinanti con il Sud Sudan. Sarebbero inoltre 7 milioni le persone bisognose di assistenza umanitaria, la maggior parte delle quali si trova in condizioni critiche.

Le forze governative sono state accusate di aver attaccato e distrutto anche le scuole e gli ospedali nelle regioni ribelli, aggravando la crisi umanitaria in corso. Anche in Sud Sudan, coloro che si sono resi responsabili dei peggiori crimini contro l’umanità non verranno probabilmente mai chiamati a rispondere delle proprie deplorevoli azioni. Un altro dato spaventoso che descrive una pratica odiosa che contraddistingue i conflitti nell’ Africa Subsahariana è quello relativo ai bambini soldato. Si calcola che dall’ottobre del 2014 al giugno del 2018 siano addirittura 6.500 i bambini reclutati da tutte le parti in lotta per il controllo del Sud Sudan. Inoltre la violenza del conflitto non ha risparmiato gli operatori umanitari: sono infatti più di 100 i volontari morti dall’inizio delle ostilità. Entrambe le fazioni hanno attaccato le organizzazioni umanitarie e i caschi blu dell’Onu dislocati nel paese, per non parlare del perdurante tentativo di sabotare l’arrivo di aiuti alle popolazioni civili in difficoltà.
Il rapporto di Human Rights Watch sottolinea come le forze governative abbiano catturato ed incarcerato un numero indefinito di persone, alcune delle quali sembrano sparite senza lasciare traccia. Nessuno dei detenuti che sono stati liberati è stato in grado di dire agli operatori umanitari le motivazioni che ne hanno determinato l’arresto e giustificato la detenzione che in alcuni casi si è prolungata per diversi mesi. Ciò non può che far pensare che si tratti di arresti condotti su base deliberatamente etnica. Secondo il New York Times, il conflitto in Sud Sudan avrebbe determinato, dal suo inizio nel 2013, la morte di 383 mila persone. Una tragedia di immani proporzioni, l’ennesima subita da un popolo che non sembra trovare pace.